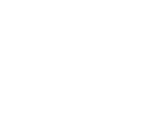Audizione del ministro dell'istruzione, Giuseppe
Fioroni, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
GIUSEPPE FIORONI, Ministro
dell'istruzione.
Ringrazio il
presidente e i colleghi parlamentari.
Mi auguro di
avere con la Commissione - questo è il mio intendimento - un rapporto franco e
chiaro di collaborazione e di confronto. Un confronto, che spero possa essere
foriero di soluzioni condivise nell'interesse della scuola italiana.
Il sistema educativo italiano sta
vivendo una fase di difficoltà: le conseguenze delle politiche scolastiche
dell'ultima legislatura si sono abbattute su un insieme di criticità irrisolte
e su ritardi accumulatisi nel tempo in diversi campi strategici. I colleghi
parlamentari e l'opinione pubblica conoscono le indagini internazionali, da cui
emergono profili non precisamente lusinghieri dei risultati scolastici del
nostro paese; e più in generale la notevole distanza che ancora ci separa dai
traguardi fissati per il 2010 dalla Conferenza di Lisbona.
Di queste
criticità, delle più antiche e delle più recenti, non intendo in questa sede-,
presentare l'elenco, né sintetico né dettagliato. E neppure attardarmi in
un'illustrazione delle specifiche responsabilità dei diversi attori; o delle
sottovalutazioni di varia natura e di diversa origine, recenti e non recenti,
che si sono scaricate su questo sistema così complesso e così delicato, di
importanza strategica per la qualità dello sviluppo civile, sociale ed
economico del nostro paese. L'attenzione di tutti, e la mia in particolare,
oggi deve concentrarsi piuttosto su quello che è necessario e possibile fare,
fin da subito e nel corso di questa legislatura.
Voglio invece
dirvi quello di cui mi sono convinto cominciando a praticare il metodo che mi
farà da bussola per tutto lo svolgimento del mio incarico, cioè l'ascolto
attento e quotidiano di chi la scuola la vive e la fa concretamente - del suo
corpo professionale, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, degli
studenti, delle famiglie -, prima e più dei molti che ne discutono da fuori e
dall'alto. Voglio dirvi, in sintesi, che a mio parere non ha orecchie per
sentire né occhi per vedere chi dalle pagine dei giornali proclama che la
scuola italiana è morta, o comunque che le sue malattie, di natura ormai
cronica, sarebbero inguaribili.
Non è affatto così. Sebbene ci
troviamo di fronte alla necessità di mettere in campo interventi capaci di
innalzare il suo livello medio di qualità - in tempi ravvicinati e in modo
omogeneo su tutto il territorio tutela nazionale -, è assolutamente evidente
che nella scuola italiana c'è una grande presenza di energie professionali
positive, che si manifestano in una crescente capacità di lettura dei bisogni
formativi dei giovani e anche del mondo dell'adulto, in un diffuso impegno
nell'innovazione, in una significativa disponibilità alla ricerca didattica sul
campo e a pratiche di sperimentazione. E, voglio sottolinearlo, in una
sensibilità preziosa - spesso più acuta e reattiva di quella di altre strutture
e servizi pubblici - nei confronti di fenomeni complessi, come l'immigrazione e
il massiccio ingresso dei suoi figli nelle nostre strutture formative, nella
nostra cultura, nella nostra vita sociale, o come l'integrazione nella scuola
di tutti, dei ragazzi diversamente abili.
Spesso tutto ciò
si realizza anche dove le condizioni strutturali della scuola e le condizioni
stesse del lavoro che vi si svolge - dalla prolungata mortificante precarietà
di troppi insegnanti ai modesti livelli retributivi - potrebbero alimentare, se
non giustificare, uno stato di scoraggiamento e di inerzia. Non è tutto così,
ma è anche così: ed è da qui, da quello che nonostante tutto si riesce in
moltissime scuole a realizzare, e dal tessuto fitto e vitale di alleanze tra
scuola e territorio che caratterizza numerose realtà del nostro paese, che
bisogna muovere. Perché l'ottimo o l'eccellente indica con chiarezza quello che
occorre contrastare e quello che occorre mettere in campo, per costruire le
condizioni e gli strumenti di uno sviluppo effettivo e generalizzato delle
risorse della scuola e delle potenzialità dell'autonomia scolastica. Perciò non
ho in animo di elaborare l'ennesima riforma complessiva del sistema, a cui
legare il mio nome. Il mio proposito è diverso. Il mio metodo è un altro.
Migliorare le condizioni di
funzionamento della scuola e dell'autonomia scolastica è un obbiettivo di
straordinaria importanza per il paese, per il suo sviluppo e per la sua stessa
identità. Il ruolo della scuola non riguarda solo la trasmissione del sapere
essenziale alla cittadinanza attiva e la formazione delle competenze culturali
e professionali necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro. La scuola non
è solo il più importante degli strumenti di riproduzione e di sviluppo della
comunità nazionale, è o può essere essa stessa un contesto comunitario e
identitario per i milioni di persone giovani e adulte che vi operano e che la
vivono direttamente. Una comunità in cui si realizzano percorsi di crescita
culturale ed umana, prove concrete di solidarietà e di coesione sociale,
esperienze di inclusione ed integrazione di alto valore civile ed etico. Non è
un caso, infatti, che l'Italia dei mille campanili è anche l'Italia che,
accanto alle autonomie locali, può far crescere una forte autonomia scolastica.
Nei quartieri
metropolitani più difficile è questa esperienza comunitaria che, in molti casi,
costituisce il presidio più importante contro l'isolamento e la solitudine
urbana. Ed è qui, quando la scuola è progetto condiviso e patto di
responsabilità, che si tessono la trama e l'ordito di appartenenza ed identità
che rispondono alle domande di senso di giovani e adulti.
Se si creano le
condizioni perché questa dimensione comunitaria possa svilupparsi pienamente e
serenamente, senza l'ossessione di trasformazioni epocali e col sostegno delle
autonomie locali e in primo luogo dei comuni, la scuola può diventare l'anima
laica della società, dove si impara a porsi le domande giuste e a trovare come
rispondervi, e a misurarsi con le responsabilità e le prove della vita adulta,
come in una terra di mezzo in bilico tra tutela e autonomia; dove i concetti e
i valori della partecipazione civile e democratica possono uscire dalle
affermazioni astratte e farsi comportamenti concreti. Non sfugge a nessuno, e
ne abbiamo numerose prove concrete anche nelle aree territoriali in cui il
tessuto democratico è più a rischio, che l'esperienza scolastica può divenire
la palestra più importante per lo sviluppo di una cultura, e perfino di una
passione, democratica dei giovani.
L'autonomia
scolastica, l'unica illuminata, e anche per questo costituzionale, riforma
degli ultimi anni, ha in sé tutte le potenzialità necessarie allo sviluppo
della dimensione comunitaria della scuola. Ma in questi anni è stata soffocata,
mortificata, non implementata. È importante, in questo quadro, un'azione del
Parlamento sugli organi collegiali di gestione dell'autonomia: attualmente,
sono anche nello scarto tra modalità di gestione della scuola e autonomia
scolastica, le ragioni del suo inadeguato o lento sviluppo. È urgente invertire
la rotta: passa anche da qui il recupero di quella credibilità sociale e di
quella dignità professionale a cui giustamente aspira il personale della
scuola, e a cui noi dobbiamo dare una risposta.
L'autonomia
scolastica e l'interazione, nei contesti locali, tra le diverse autonomie,
costituisce il quadro di riferimento principale dei processi di innovazione e
di riqualificazione, di cui l'intero sistema educativo ha bisogno. Pretendere
di imporla dall'alto, con atti dirigistici, legislativi o amministrativi,
sarebbe un grave errore, condannato in partenza all'incomprensione e
all'inefficacia. Ciò che occorre non è una logica abrogativa, che sarebbe
connotata inevitabilmente da rischi conservativi, né tanto meno la
restaurazione - evocata da non poche cassandre - di una scuola del passato, che
non può esserci perché è scomparso il suo mondo di riferimento. Ma, d'altro
canto, bisogna evitare la pretesa, ancora una volta, di cambiare tutto e
subito, anche se il nostro sistema educativo ha senza alcun dubbio bisogno di
molte profonde innovazioni.
La via giusta, in un sistema
fondato sulle autonomie, è quella dell'attivazione di processi di
trasformazione condivisi: da un lato smontando, con il metodo del «cacciavite»,
ciò che li frena o li ostacola, dall'altro mettendo in campo ciò che occorre
perché quei processi abbiano come traguardo una maggiore efficienza e una
maggiore equità.
È allo Stato che
spetta definire gli indirizzi e gli obiettivi formativi, ed è lo Stato che ha
la responsabilità di indicare i criteri di riferimento dell'azione delle
autonomie scolastiche funzionali e di costruire i dispositivi di verifica
oggettiva e scientifica dei risultati del sistema. Ma il metodo, che è sempre
sostanza anche della politica, deve essere quello della concertazione con le
scuole e tra le scuole e delle intese con gli attori istituzionali - le regioni
e le autonomie locali - che hanno competenze sul sistema educativo. La
filosofia della concertazione non deve rinchiudersi nel solo ambito dei rapporti
interistituzionali. Abbiamo bisogno di processi larghi e plurimi di
condivisione delle scelte; quindi del contributo attivo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni professionali, delle associazioni dei genitori e
degli studenti. Quanto maggiore sarà la loro rappresentatività e la loro
capacità di dialogo, superando logiche autoreferenziali o di nicchia, tanto più
efficaci saranno i processi e i risultati della concertazione.
È stato questo l'approccio che ha
guidato il primo incontro del 15 giugno scorso con le regioni, in cui sono
stati concordati i primi impegni comuni. L'obiettivo è di procedere ad intese,
che devono coinvolgere anche le province e i comuni, per la qualificazione di
un sistema educativo unitario, di validità nazionale, fuori e contro ogni
rischio di segmentazione territoriale, che produrrebbe insostenibili
diseguaglianze dei giovani e delle famiglie nell'accesso all'istruzione e nella
qualità dei suoi processi formativi e dei suoi risultati. La declinazione
dell'offerta formativa secondo i bisogni formativi del territorio, che è
necessaria, non può però in nessun modo e in nessun caso dar luogo ad un
diritto all'istruzione diversificato secondo il luogo di residenza e secondo le
caratteristiche economiche e sociali dell'origine familiare.
La nostra
Costituzione è assolutamente chiara a questo proposito: il diritto
all'istruzione, come il diritto alla salute, è universalistico, e deve essere
assicurato dalla Repubblica indipendentemente dalle condizioni sociali ed
economiche, dal sesso, dalle opinioni politiche, dalle scelte religiose. A
maggior ragione, in questo quadro, il diritto all'istruzione deve essere
indipendente dal luogo in cui alle persone sia capitato di nascere o di
risiedere.
All'indomani del
risultato referendario, possiamo dire con soddisfazione che la grande
maggioranza del paese ha capito perfettamente il significato del diritto
costituzionale, di tipo universale e solidaristico, all'istruzione e la portata
della minaccia, a questo come ad altri diritti universalistici, rappresentata
dalla cosiddetta devolution.
La scuola che
vogliamo è una scuola capace di coniugare equità ed eccellenza, capace di
garantire le pari opportunità di tutti nell'accesso all'istruzione e nella
possibilità di successo formativo, l'eccellenza dei risultati, la
valorizzazione dei meriti individuali.La scuola deve tornare a svolgere un
ruolo decisivo rispetto alla mobilità sociale, assicurando non solo che ogni
studente possa realizzare appieno le proprie potenzialità, seguendo in libertà
e responsabilità le proprie propensioni ed attitudini, ma anche accompagnando
al successo formativo e ai percorsi di istruzione superiore i giovani migliori,
qualsiasi sia la loro condizione di partenza.
Sono segni inquietanti per le
prospettive di sviluppo del paese i fenomeni di stagnazione sociale su cui il
CENSIS è tornato con una sua recente indagine, il peggioramento delle
condizioni dei figli rispetto a quelle dei padri, la riproduzione incessante,
fin dalla scuola di base, del peso dei condizionamenti del contesto familiare
di appartenenza sul successo scolastico e formativo.
Don Milani
scriveva, nei primi anni sessanta del secolo scorso, che doveva esserci
qualcosa di sbagliato in una scuola e in una società in cui i figli dei poveri
risultavano essere, immancabilmente, «i più cretini». Come commenterebbe oggi,
a 43 anni dall'istituzione della scuola media unica e obbligatoria e a distanza
di trent'anni dall'avvio della scolarizzazione di massa, il fatto che solo l'8
per cento dei figli dei ceti popolari arriva a laurearsi? E il fatto che sul
successo scolastico dei ragazzi incide, ancora di più delle condizioni
economiche della famiglia, il titolo di studio dei genitori?
In una società
in cui l'apparire vale più dell'essere, l'essere meno dell'avere, le
appartenenze più delle competenze e le fedeltà più dei meriti individuali, è
importante che almeno nella scuola si sappia andare controcorrente e che i
giovani imparino a rispettare valori diversi. Ma questo non può avvenire se le
capacità e l'impegno individuale dei singoli non vengono riconosciuti e
valorizzati. Dobbiamo sostenere ed incentivare l'impegno dei giovani a
raggiungere l'eccellenza, dentro la scuola e nei percorsi formativi superiori.
Ho voluto, fin dai primi giorni del
mio incarico, tornare alla definizione del Ministero come Ministero della
pubblica istruzione, per precisare un concetto - e un valore - a cui tengo
molto e a cui tutti dobbiamo tenere. Cioè che in democrazia l'istruzione è una
funzione pubblica, è un servizio pubblico, perché riguarda tutti e perché le
sue finalità sono decise dalla comunità, e che tale è e resta,
indipendentemente dalla natura del soggetto che gestisce l'offerta formativa,
sempre che il soggetto gestore risponda a quelle finalità e alle regole che ne
derivano. Tutto ciò è già scritto nella legge n. 62, varata dal centrosinistra,
sulla parità scolastica. Sono molto preoccupato del taglio pesante, di 167
milioni di euro, che il precedente Governo ha operato su questo capitolo. Il
rischio maggiore riguarda il diritto dei bambini e delle famiglie alla scuola
per l'infanzia, per il peso specifico in questo campo che hanno le scuole
paritarie, in particolare in molti piccoli centri e nelle zone di montagna.
Queste risorse dobbiamo recuperarle e orientarle su questa priorità.
Funzione
pubblica significa anche, scavando più a fondo, che la scuola non può lasciare
indietro nessuno; che deve prendersi cura anche e soprattutto di chi ha
problemi, di chi non ce la fa da solo. Anche qui soccorrono le parole della Lettera
a una professoressa di Don Milani, che ironizzava spietatamente su una
scuola che ritenesse di essere fatta solo per quelli capaci di apprendere da
sé: proprio come un ospedale che ritenesse di doversi occupare dei sani, invece
che dei malati.
Voglio dire
qualcosa, a questo proposito, su tre temi della massima importanza per il ruolo
e la qualità del nostro sistema educativo: l'integrazione scolastica dei
diversamente abili, gli immigrati stranieri e l'interculturalità, l'educazione
degli adulti.
Tra le nostre specificità positive
in ambito europeo c'è l'integrazione dei disabili nella scuola di tutti. Nessun
altro sistema educativo ha a questo proposito norme così perentorie come le
nostre. Dobbiamo esserne orgogliosi. Nel 2003-2004 gli allievi diversamente
abili erano 161.159: l'1,8 per cento del totale degli studenti, il 2,3 per
cento nella scuola primaria, il 2,8 per cento nella scuola media, l'1,2 per
cento nella scuola superiore. Un significativo aumento di questi allievi si è
avuto negli ultimi cinque anni, anche nelle scuole non statali (0,5 per cento):
l'inserimento di questi allievi, infatti, è uno dei requisiti richiesti per il
riconoscimento di scuola paritaria. Ma dobbiamo anche migliorare le condizioni
e gli strumenti di una integrazione scolastica efficace, rivedendo l'organico
degli insegnanti di sostegno, i criteri della loro distribuzione e la loro
preparazione professionale, perché siano funzionali ai bisogni effettivi dei
ragazzi diversamente abili e alla classe in cui essi sono inseriti; ottenendo
dalle ASL diagnosi effettivamente funzionali; superando le difformità
dell'integrazione scolastica tra scuola di base e scuola secondaria superiore;
costruendo le condizioni per un'organizzazione della didattica più flessibile
ed aderente ai bisogni individuali e alle classi di appartenenza; dotando le
scuole della strumentazione tecnologica necessaria. Dobbiamo anche, utilizzando
le anagrafi sanitarie, portare dentro la scuola i ragazzi diversamente abili
che ancora ne sono fuori.
La specializzazione
degli insegnanti di sostegno deve essere pienamente valorizzata e sottratta al
rischio che vada dispersa per convenienze di vario tipo. Ma è evidente che, per
l'integrazione dei ragazzi in difficoltà, è importantissima anche la competenza
e l'impegno professionale degli insegnanti curricolari, e di questo dobbiamo
prenderci cura. Come primo intervento su questo insieme di problemi, ritengo
importante rimuovere il bizzarro, e privo di ogni fondamento scientifico,
criterio di definizione degli organici degli insegnanti di sostegno, che era
stato introdotto recentemente: quel criterio che, con logica tipicamente
aziendalistica, calcolava il numero degli insegnanti di sostegno necessari sul
numero totale degli allievi, invece che sul numero degli allievi disabili. Per
l'approfondimento degli altri temi è stato immediatamente attivato il rapporto
con l'Osservatorio sull'handicap e con le associazioni che se ne
occupano.
Tornando al
tema, anche a questo proposito, è essenziale il rapporto con la scuola reale,
sia per avere il quadro esatto delle criticità sia per raccogliere nuove
proposte. Se l'integrazione scolastica dei diversamente abili è sempre un
vantaggio per i ragazzi che non lo sono, perché possono nell'incontro
quotidiano con loro maturare capacità di rispetto e di relazionalità
importantissime per la propria formazione umana, bisogna trarre, da una pratica
di integrazione ormai trentennale, tutte le indicazioni utili a migliorare
l'inserimento dal punto di vista della sua efficacia sulla crescita dei ragazzi
in difficoltà.
Un tema
strategico è costituito anche dall'impatto nella nostra scuola dell'inserimento
dei figli dell'immigrazione: nel 2003-2004 erano più di 300 mila, presenti
ormai nel 52,9 per cento degli istituti scolastici. La maggior parte degli
stranieri si iscrive nella scuola statale (271.718), solo 31.556 sono in quella
non statale. Il maggiore addensamento di iscrizioni è nella scuola primaria
(4,7 per cento) e nella scuola media (4,1 per cento), mentre siamo solo all'1,9
per cento - ma in crescita, evidente, negli ultimi anni - nella scuola
secondaria superiore. I valori più alti sono nelle regioni del nord: il più
alto è in Emilia-Romagna (6,4 per cento), seguita da Lombardia, Veneto, Marche.
Il più basso in Sardegna (0,5 per cento).
Se l'accoglienza
è, nell'insieme, di buon livello, è però evidente che il percorso scolastico
dei ragazzi stranieri si presenta più difficile che per gli studenti italiani.
I ritardi e gli insuccessi sono più numerosi fin dalla scuola di base: già nella
scuola elementare si riscontra un 3,4 per cento in più di non promossi tra gli
stranieri, e un 7,1 per cento in più nella scuola media. Lo scarto è ancora più
vistoso nella scuola secondaria superiore, dove raggiunge il 12,6 per cento.
Tutto ciò incide non poco sugli indici di passaggio dalla scuola di base ai
percorsi scolastici e formativi successivi e costituisce un pericolo evidente
per l'integrazione sociale e professionale dei giovani immigrati di seconda
generazione.
È invece
sostenuto l'incremento di allievi stranieri nei percorsi di formazione
professionale successivi alla scuola media, nei corsi serali per lavoratori
studenti della scuola secondaria superiore e nei corsi dei centri territoriali
per l'educazione degli adulti.
Sono dunque necessari
alcuni interventi di miglioramento delle condizioni dell'integrazione, a
partire dall'apprendimento della lingua italiana come lingua seconda per i
ragazzi e per i loro genitori. Se per il successo scolastico dei ragazzi
italiani conta moltissimo - e in verità troppo - il livello di istruzione dei
genitori, il fatto che, in molti nuclei familiari immigrati, gli adulti non
padroneggino la lingua italiana è un fattore di forte svantaggio per i loro
figli. La scuola come comunità deve significare una responsabilizzazione anche
nei confronti delle famiglie dei ragazzi stranieri.
Anche alcuni contenuti culturali
della scuola dovrebbero ampliarsi ed arricchirsi. Se l'asse culturale della
nostra scuola deve avere al centro le radici culturali europee e sviluppare tra
i giovani la comprensione e l'interiorizzazione della nuova dimensione europea
e delle tradizioni, storie e culture, che vi sono sottese e che la rendono
possibile, i contenuti dell'apprendimento devono essere tali da facilitare il
rapporto e lo scambio anche con le altre culture e le altre identità. È un
problema che, nel mondo globalizzato di oggi, riguarda la formazione di tutti.
Devono inoltre essere messe in campo politiche, anche di formazione degli
insegnanti, che favoriscano attraverso la didattica il dialogo e la formazione
interculturale.
Dobbiamo sapere
che passano largamente dalla scuola le possibilità di costruire una società
insieme plurale e coesa, in cui gli stranieri non siano considerati come ospiti
in prova perenne, ma come nuovi cittadini, con diritti e doveri, e in cui anche
il paese che accoglie sia disponibile e in grado, pur senza rinunciare alle
proprie specificità, di misurarsi con l'apporto delle culture degli altri. Un
proposito difficile e tuttavia essenziale, che ha bisogno di una scuola che
faccia da ponte tra le culture di provenienza e quella di arrivo e che sia
capace di contribuire al mantenimento delle lingue e delle culture di
appartenenza. È grande la responsabilità del sistema educativo nel favorire, a
partire dal riconoscimento delle nostre comuni radici europee, la crescita tra
le nuove generazioni di un nuovo umanesimo, la transizione ad una società
sempre più umanizzata ed aperta.
In questo
quadro, sono grandi le potenzialità positive, che possono avere le istituzioni
educative italiane e i giovani che le frequentano, per costruire rapporti di
dialogo e di pace nel Mediterraneo, con i paesi dell'altra sponda, con il Medio
Oriente, con le popolazioni arabe e con l'Islam moderato. Devono essere
valutate con attenzione e rispetto le richieste delle comunità di aprire la
nostra scuola anche ad occasioni di apprendimento delle lingue e delle culture
di origine.
Voglio, infine,
sollevare un tema di straordinaria importanza, che è invece solitamente
relegato in posizione marginale nel dibattito e nelle politiche scolastiche,
cioè l'educazione degli adulti come elemento essenziale della strategia
dell'apprendimento lungo tutto il percorso della vita.
Sviluppare
l'educazione degli adulti dentro il nostro sistema di istruzione e formazione
ci interessa per vari ordini di motivi: perché il basso livello di istruzione
dei genitori ha un'influenza determinante nell'insuccesso scolastico dei
ragazzi; perché i limiti gravi, che ancora registriamo nella diffusione delle competenze
di base ed alfabetiche nella popolazione adulta, anche di fasce di età giovani,
è un ostacolo fortissimo per lo stesso accesso dei lavoratori alle opportunità
di formazione professionale continua e, più in generale, per l'esercizio della
cittadinanza attiva; perché in un mondo del lavoro caratterizzato da processi
di trasformazione tecnologica e produttiva, la presenza di quote molto
consistenti di lavoratori con modestissimi livelli di competenze di base e
funzionali si traduce in rischi molto forti di marginalizzazione professionale
e sociale, in contraddizioni per il paese, in ostacoli alla sua crescita.
Non dobbiamo dimenticare che solo
nel 2003 siamo per la prima volta scesi al di sotto del 30 per cento di
cittadini adulti con al massimo la licenza elementare; che il possesso di un
diploma - che oggi è la soglia di istruzione considerata essenziale (come è
stata la licenza elementare negli anni cinquanta e la licenza media negli anni
settanta) - riguarda solo poco più del 40 per cento degli adulti in età da
lavoro; che tornano in formazione da adulti soprattutto le persone che hanno
già un livello di istruzione di livello medio ed alto, perché la «formazione
chiama formazione» e perché le aziende investono soprattutto, se non
unicamente, sui lavoratori meglio dotati culturalmente e meglio collocati
professionalmente.
E neppure
dobbiamo dimenticare quello che una recente indagine Eurostat ci segnala, cioè
che, dopo anni di retorica sull'importanza fondamentale nella vita e nel lavoro
del linguaggio dell'informatica, la gran parte degli adulti non è in grado di
aprire un personal computer e fra questi compare anche un 28 per cento riferito
ai più giovani.
Le strutture
scolastiche italiane dedicate all'educazione degli adulti sono una realtà già
oggi piuttosto importante. Nel 2003-2004 gli iscritti ai nostri centri
territoriali per l'educazione degli adulti sono stati 470 mila, di cui il 26
per cento erano stranieri immigrati, per un terzo almeno diplomati e laureati,
che imparano l'italiano e che conseguono, in mancanza di riconoscimento del
loro titolo di studio, la licenza media. Mentre gli iscritti ai corsi serali
della scuola superiore per il conseguimento di qualifiche professionali e
diplomi hanno ricominciato a crescere e sono oggi più di 60 mila.
Anche in questo
caso abbiamo esperienze di straordinaria vitalità e qualità; ma anche qui
occorre sviluppare, qualificare, innovare sia con interventi e dispositivi
specifici, sia promuovendo, come previsto nel programma del Governo, una
norma-quadro basata sul diritto dell'apprendimento lungo tutto il corso della
vita come diritto soggettivo di tutti, lavoratori e non lavoratori. Occorrerà
anche riattivare l'accordo del 2 marzo 2000 della Conferenza unificata, rimasto
da allora congelato.
L'offerta per adulti di cui
attualmente disponiamo è infatti largamente inadeguata a una domanda potenziale
in continua crescita; non è ancora sufficientemente coordinata ed integrata; è
troppo limitata e rigida sul versante del conseguimento dei diplomi, che costituisce
oggi la nuova frontiera per i giovani adulti, italiani e immigrati; ha urgente
bisogno di criteri di riferimento oggettivi e validi dovunque per la
certificazione delle competenze acquisite per via non formale e per il
riconoscimento dei crediti; non è sostenuta, come dovrebbe, da efficaci servizi
di orientamento sul territorio e di bilancio delle competenze. Nel corso della
legislatura sarà necessario promuovere, d'intesa con le autonomie locali, una
campagna di sviluppo della domanda di istruzione e di formazione degli adulti,
in particolare dei genitori di ragazzi in età scolare.
Ma dobbiamo,
contestualmente, evitare il rialimentarsi continuo del bacino dei troppo pochi
istruiti. A questo proposito, la madre di tutte le battaglie consiste nel contrastare
le patologie dell'insuccesso scolastico, della demotivazione all'apprendimento,
degli abbandoni. Patologie che portano, com'è noto, a un indice di diplomati
pari al 72 per cento dei ventenni, contro l'80 per cento della media europea,
ma inferiore anche di 15-20 punti percentuali rispetto ai paesi con le performance
migliori.
Non c'è una ricetta unica e nessuna
ricetta è semplice. Il funzionamento della scuola e i suoi risultati non
dipendono solo dalla sua fisionomia strutturale e neppure solo dalla sua
durata. Se fosse così, il nostro paese, che diploma i suoi giovani dopo 13 anni
di scuola e a 19 anni, mentre altrove il percorso scolastico è più corto e
l'età di uscita è a 18 anni, dovrebbe essere in vantaggio. Ma le indagini
internazionali comparate ci dicono cose diverse. Per avere chiaro il quadro
della complessità dell'impresa è importante sottolineare tre dati
incontrovertibili. Il primo è che già nella scuola media più del 2,5 per cento
dei ragazzi ne esce ogni anno senza aver conseguito il titolo: una condizione
che rende impossibile accedere a qualsiasi ulteriore percorso formativo di
carattere formale, anche nella formazione professionale, e che condanna, se non
si predispongono percorsi di recupero dei titoli di studio (oggi l'unica strada
è, notoriamente, nei corsi dei centri per l'educazione degli adulti,
finalizzati al conseguimento della licenza elementare e media), a rischi molto
alti di marginalità lavorativa e sociale. Non solo. Quasi la metà dei
licenziati della scuola media ne esce con la valutazione di «sufficiente», che
significa aver già accumulato deficit di vario tipo nelle competenze di
base e affrontare in condizioni difficili la scuola secondaria superiore, nelle
cui prime classi, infatti, esplodono i più gravi fenomeni di dispersione.
Il secondo dato è che il tasso di
passaggio dei licenziati dalla scuola media alla scuola media superiore ha
raggiunto il 97 per cento, con un andamento in ulteriore crescita. La
situazione, dunque, è molto diversa da quella degli anni settanta, quando
l'obbligatorietà dell'istruzione era lo strumento principe, simbolico e
fattuale, per forzare la resistenza di quote ancora importanti delle famiglie
ad investire nell'istruzione lunga dei figli. Oggi, il nostro problema è quello
di quel 25 per cento di 14-18enni, che alle superiori ci è andato, ma che poi
le ha abbandonate o ne è stato espulso. È dunque indispensabile assicurare le
condizioni di una prevenzione e di un recupero della dispersione, attraverso
azioni didattiche e percorsi capaci di motivare e di rimotivare, di compensare
i deficit accumulati, di assecondare e valorizzare le propensioni, gli
interessi, gli stili di apprendimento, le intelligenze, i talenti di ogni
ragazzo e di ogni ragazza. È un problema fatto principalmente di fisionomia e
di flessibilità dei curricula, di qualità e specializzazione della
didattica, di capacità delle autonomie scolastiche di integrazione dei
percorsi, di orientamento, che non si risolve con scelte di tipo esclusivamente
ordinamentale e che richiede di agire contestualmente su molti e diversi
fronti.
Il terzo dato è
che in Italia, come in tutti i paesi dell'Unione europea, si ha diritto di
entrare nel lavoro anche prima dei diciotto anni e che sono una percentuale non
insignificante i ragazzi che utilizzano questa possibilità: per le più diverse
ragioni, non riconducibili unicamente all'insuccesso o alla dispersione
scolastica o a difficili condizioni economiche, ma anche all'attrazione del
lavoro come strumento di autonomia e come via per raggiungere un'identità
adulta. Nel programma del Governo abbiamo previsto l'innalzamento dell'età
dell'ingresso al lavoro dai quindici ai sedici anni, in coerenza con il
prolungamento di due anni dell'obbligo scolastico. È un obiettivo importante,
ma è evidente che non basterebbe, se non venisse accompagnato dalla
predisposizione di percorsi misti tra formazione e lavoro in grado di
assicurare il conseguimento di qualifiche professionali e, comunque, di crediti
per il conseguimento dei diplomi. Dobbiamo tornare, quindi, sulla questione
dell'apprendistato formativo, che non è stata affatto risolta da quanto prevede
in proposito la legge n. 30 del 2003, e dobbiamo negoziare le condizioni perché
non ci sia attività lavorativa, al di sotto dei diciotto anni, che non abbia una
prevalente dimensione formativa e che non conduca al conseguimento di
qualifiche professionali e/o di crediti riconoscibili per il proseguimento in
percorsi formativi ulteriori di carattere formale.
Contrastare la dispersione, dunque,
significa agire sia sul versante della prevenzione, che su quello della
compensazione. Significa non solo concentrare l'attenzione sulla fascia d'età
dei 14-16 anni, ma agire anche prima ed anche dopo, accogliendo l'indicazione
dell'Unione europea che considera strategico l'intervento per il conseguimento
dei diplomi e delle qualifiche nella fascia di età fino ai venticinque anni.
Significa adottare l'approccio del lifelong learning, tipico di una
società democratica ed aperta, che significa non dare mai per scontato che la
prima volta è quella definitiva e che le scelte e i risultati siano
irreversibili. Significa prendere sul serio le strategie dell'orientamento.
Significa intervenire sul cuore dell'apprendimento, che è la qualità della
relazione educativa, e quindi sulla cultura professionale degli insegnanti e
sulla qualità della didattica. Significa non lasciare mai sola la scuola,
favorendone l'alleanza con le forze vive e con le risorse del territorio. Ed
infine significa non dimenticare, anche in questo caso, quella splendida
lezione che ci dice che non c'è ingiustizia peggiore che presentare la stessa
identica minestra a persone con gusti e stomaci diversi: il risultato sarà che
molti non digeriranno o smetteranno di mangiare.
Anche su questo
tema, non mancano nel sistema educativo italiano le esperienze di eccellenza,
da prendere come base di partenza per l'elaborazione di nuove strategie.
Ci sono piste e risultati
interessanti anche nei discussi percorsi sperimentali triennali, attivati a
partire dal 2003-2004 dalle regioni, che integrano variamente scuola e
formazione professionale; apprendimenti teorici e apprendimenti in laboratorio
e in contesti operativi; sapere, saper fare, saper essere; scuola, formazione,
orientamento, esperienze di laboratorio e di lavoro. In diverse realtà,
infatti, la dispersione sta diminuendo ed una percentuale consistente degli
allievi, conseguita la qualifica professionale, rientra nei percorsi di
istruzione. Si tratta, anche dal punto di vista quantitativo, di un'esperienza
non molto significativa, ma di certo non insignificante. Gli allievi dei
percorsi triennali sono, oggi, 74 mila, più nelle prime che nelle classi
successive, con un evidente incremento della domanda, in diverse realtà non
soddisfatta, per l'insufficienza delle risorse destinate dal nostro Ministero e
da quello del lavoro. Allo stesso motivo si deve il fatto che solo in tre
regioni sia stato attivato il previsto quarto anno di specializzazione
professionale.
Non si tratta
assolutamente di modelli generalizzabili su scala nazionale, sia perché le
tipologie attivate dalle regioni sono piuttosto diversificate nelle diverse
realtà territoriali, sia perché non dovunque i sistemi locali di formazione
professionale sono adeguati per quantità e qualità ad integrarsi con la scuola
o a sviluppare percorsi autonomi con le prerogative richieste. Si tratta, però,
di esperienze rivelatrici di logiche e metodi interessanti, di esperienze che
mettono in atto dispositivi innovativi di orientamento, certificazione dei
crediti, definizione degli standard, formazione congiunta degli
insegnanti e dei formatori, da cui è possibile e necessario trarre stimoli ed
indicazioni concrete per mettere sui binari giusti la lotta alla dispersione.
La priorità che
dobbiamo attribuire alla lotta alla dispersione - lo ripeto ancora una volta -
non può lasciare in ombra il traguardo dell'eccellenza. Equità ed eccellenza
vanno sempre di pari passo. Il sistema educativo deve saper promuovere le
intelligenze migliori. E la Repubblica, come dice la Costituzione, deve
sostenere l'impegno dei singoli al raggiungimento dell'eccellenza. In altri
paesi europei questo è un elemento decisivo delle politiche educative: dovremo
anche noi predisporre incentivi adeguati in questo senso per i nostri studenti.
Vengo al tema della scuola per
l'infanzia. Per una scuola che non lasci indietro nessuno e che sviluppi, fin
dai primi anni di vita, la capacità di apprendimento di tutti, assicurando una
crescita equilibrata dei bambini anche dal punto di vista affettivo e relazionale,
è indispensabile intervenire sulla scuola per l'infanzia. Dobbiamo garantire,
infatti, in tutte le aree del paese, a partire dal Mezzogiorno, un pieno
equilibrio tra domanda ed offerta. Si tratta di un diritto fondamentale per i
bambini dai tre ai sei anni, ma anche per le famiglie, in particolare per le
mamme che lavorano o vorrebbero lavorare. Le politiche per la scuola
dell'infanzia - il suo sviluppo quantitativo, la sua qualità - fanno parte a
pieno titolo delle politiche per le pari opportunità tra uomini e donne
rispetto al lavoro.
Oggi, la
partecipazione dei bambini alla scuola per l'infanzia, tra scuole statali,
comunalie paritarie, è molto alta e supera il 97 per cento (il 58 per cento dei
bambini sono nelle scuole statali). Se consideriamo che la scuola dell'infanzia
non è una scuola obbligatoria, ci rendiamo facilmente conto di che cosa questa
partecipazione significhi. Essa è il segno di una diffusa consapevolezza delle
famiglie dell'importanza della socializzazione dei bambini - tanto più acuta in
una società di «figli unici» - e dello sviluppo delle capacità espressive,
motorie e cognitive anche prima dell'infanzia nella scuola di base. Ma è anche
il segno di un forte bisogno delle famiglie, non più concentrato solo nelle
aree urbane, di contesti affidabili e di qualità, per la protezione e
l'educazione dei figli, anche nei primi anni di vita. Dietro a tutto ciò ci
sono anche le nuove famiglie, sempre più prive delle reti familiari allargate
di una volta, e la crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Una scuola per l'infanzia di qualità, d'altro canto, è un efficace strumento
per intervenire per tempo sulle disuguaglianze derivanti dalle condizioni
sociali, economiche e culturali delle famiglie di origine, ma anche sui deficit
sensoriali e linguistico-comunicativi dei bambini. Ma non in tutte le scuole
per l'infanzia c'è la possibilità del servizio anche postmeridiano e serie
carenze - edilizie e di servizi - si registrano nei piccoli centri e nelle aree
urbane di recente insediamento. Lo sviluppo della scuola per l'infanzia rende
necessario un impegno condiviso tra Stato e comuni, a cui spetta l'attuazione
dei servizi di mensa e di trasporto, oltre che la predisposizione degli
edifici, e un miglior coordinamento tra scuole statali, comunali e paritarie.
Anche l'anticipazione dell'età di iscrizione alla scuola per l'infanzia si
iscrive, con tutta evidenza, in questo quadro. Come è noto, essa richiede
l'attivazione da parte dei comuni di condizioni logistiche, di servizi e di figure
professionali aggiuntive e ciò non è facilmente realizzabile dovunque in tempi
brevi. Per questo ho proposto il rinvio dell'entrata a regime
dell'anticipazione, ritenendo che questa appartiene alla riforma di quella
scuola che ancora i nostri comuni non sono in grado di potersi permettere.
Per quanto
riguarda il tempo pieno e il tempo prolungato nella scuola di base, tra gli
impegni dell'oggi, c'è il ripristino delle condizioni che consentano alle
autonomie scolastiche di attuare il tempo pieno e il tempo prolungato come un
modello didattico declinato sulla domanda delle famiglie e sui bisogni
educativi degli allievi nei diversi contesti territoriali. Lo spacchettamento
del monte-ore nella somma di attività diverse, determinato nella precedente
legislatura, oltre a provocare rischi di privatizzazione familistica del curriculum,
ha riproposto una divisione tra il tempo dell'istruzione e il tempo dei
servizi, che la scuola italiana aveva superato da trent'anni, mortificando le
prerogative e le responsabilità dell'autonomia scolastica e della
comunità-scuola.
Sulle caratteristiche del modello
didattico, così come sulla strutturazione dei curricula, l'impegno ad
evitare qualsiasi forzatura statalista e dirigista è totale. In questo quadro,
è da rivedere anche la logica implicita nell'emanazione delle «Indicazioni
nazionali».
Lo Stato non è
portatore di una sua pedagogia e di una sua metodologia didattica. Il suo
compito è un altro, quello di definire gli obiettivi formativi, sulla cui base
diventa possibile anche una seria e scientifica valutazione dei risultati del
sistema e delle singole istituzioni scolastiche, mentre è alle autonomie
scolastiche e alla capacità professionale dei docenti, che spetta la
progettazione dei curricula.
Anche sui
dispositivi introdotti dal Governo precedente, come il portafolio e il tutor,
l'azione del Governo non riguarda solo l'emendamento di ciò che è inadeguato o
non praticabile. La nostra bussola sta nel restituire all'autonomia scolastica
le scelte che le spettano e la sua piena responsabilità.
Sottolineo,
inoltre, la necessità di rendere pienamente attuativo ciò che è già previsto
nelle norme, cioè lo sviluppo della continuità educativa all'interno della
scuola di base. Un principio, quello della continuità, espressamente previsto
per legge, che dovrà trovare strumentazioni efficaci anche nei percorsi
ulteriori: di tipo verticale, tra scuola di base e secondo ciclo, tra questo e
l'istruzione e formazione superiore; di tipo orizzontale, tra i diversi
indirizzi, le diverse opportunità formative, l'istruzione, la formazione, il
lavoro.
Quanto al tema
del superamento del precariato, l'altissimo numero di insegnanti precari
costituisce un'emergenza di primaria importanza.
Sono iscritti nelle graduatorie
permanenti 313.842 insegnanti non di ruolo, di cui 157.830 - i cosiddetti
«precari storici» - hanno un'anzianità di servizio di almeno trecentosessanta
giorni. A questi ultimi si aggiungeranno, nel 2007-2008, altre 67 mila docenti,
che stanno ultimando i corsi speciali abilitanti previsti dalla legge n. 143
del 2004. Sempre nello stesso anno, ai 152.850 aspiranti con meno di
trecentosessanta giorni di servizio se ne aggiungeranno altri 20 mila, che nel
frattempo concluderanno i corsi delle scuole di specializzazione di istruzione
secondaria.
Nel 2006-2007, i
posti disponibili e vacanti sono 62.461, di cui 29.463 da turn-over. Con
decreto interministeriale sono state autorizzate 20 mila nomine per il
2006-2007 e 10 mila nomine per il 2007-2008. Per altre 20 mila nomine, è stata
richiesta l'autorizzazione il 31 maggio del corrente anno.
Sono numeri che
danno l'idea dell'enorme sproporzione tra aspiranti e posti effettivamente
disponibili, ma insieme dell'abnorme sviluppo di un precariato alimentato
incessantemente da alcune regole vigenti, relative alle supplenze brevi e alla
loro copertura, alla fisionomia delle cattedre e alle modalità di assegnazione
dell'organico. Sappiamo, d'altro canto, che le esigenze che si determineranno
per i pensionamenti dei prossimi anni sono anch'esse imponenti e che vi sono
potenzialità interessanti di aumento dei posti disponibili connesse allo
sviluppo di alcuni settori strategici, dall'educazione degli adulti
all'istruzione tecnico-professionale superiore, dalla generalizzazione della
scuola per l'infanzia agli incrementi di scolarità derivanti dall'immigrazione
straniera.
Ma intanto il precariato
costituisce un'emergenza per la stessa qualità del sistema educativo. Non si
può pretendere, infatti, di coinvolgere tutti gli insegnanti nella ricerca didattica
e nei processi di modernizzazione ed innovazione del sistema, di contare - come
modo principale per migliorare la scuola - sulle loro capacità, se una parte di
essi non avverte situazioni di stabilità e di certezza. La mortificazione
professionale non è mai una buona compagnia nel lavoro, tanto meno lo è in una
professione che richiede comportamenti attivi, capacità relazionali,
investimento continuo e di lunga durata sugli altri e su sé stessi.
Abbiamo bisogno,
inoltre, di un ricambio generazionale, in una categoria con un livello medio di
età molto alto, ed anche di una maggiore presenza nell'insegnamento,
soprattutto nella scuola per l'infanzia, di docenti maschi. La stabilizzazione
progressiva del precariato, dunque, non è solo un problema, è anche una
risorsa, e fa parte di una strategia che comincia ad essere fortemente
caldeggiata anche in ambito europeo ed internazionale: quella di rendere più
attraente la professione per i nostri laureati. L'immissione in ruolo di quote
importanti degli aspiranti, se sostenuta da efficaci interventi di formazione e
lavoro, può contribuire al miglioramento della qualità media del nostro sistema
educativo.
Occorre
affrontare il problema in diversi modi. Si tratta, in primo luogo, di procedere
alla stabilizzazione progressiva degli insegnanti precari su posti disponibili
e su quelli che, via via, si libereranno per i pensionamenti, ma anche di dar
vita ad un piano pluriennale che, agendo sui criteri di assegnazione degli
organici, sull'ampliamento delle aree disciplinari di riferimento, sulla
gestione delle supplenze brevi da parte delle autonomie scolastiche, consenta
il contenimento della riproduzione e dell'espansione del precariato.
Ci sono, poi,
connessioni importanti tra il superamento del precariato docente e la
realizzazione di efficaci percorsi di formazione iniziale. È un campo molto
problematico, che richiede un approfondimento preliminare all'assunzione di
adeguate decisioni.
Meno problematica, ma molto
drammatica, e anch'essa importante, è la situazione del precariato non docente:
nel 2006-2007, gli aspiranti non di ruolo sono 66.009, su un totale di 78.288
posti disponibili e vacanti (di cui 8.167 da turn-over). In questo
settore di lavoro è, peraltro, urgente una ridefinizione dei fabbisogni professionali
effettivi nella scuola dell'autonomia. Per il momento, abbiamo chiesto, oltre
ai 3.500 posti già concessi, un ampliamento di altre 3.500 immissioni in ruolo.
In materia di
edilizia scolastica e sicurezza degli edifici. Da qualche anno la legge n. 23
del 1996 - anno quindi recentissimo - non è stata più finanziata. Eppure, è di
tutta evidenza che l'edilizia scolastica ha un'importanza determinante per una
piena fruizione del diritto allo studio e per un buon funzionamento del sistema
educativo. Allo stato attuale, le carenze strutturali sono assai estese,
soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, e si riferiscono, oltre che
all'insufficienza ed inidoneità dei locali, anche al mancato rispetto delle
norme di sicurezza. È noto, inoltre, che le carenze edilizie costituiscono un
vincolo rilevante al processo di generalizzazione della scuola per l'infanzia
e, più in generale, ad una didattica che valorizzi le attività di laboratorio,
che dia spazio e significato alla creatività e all'innovazione.
Ma l'emergenza è
la sicurezza. Non è più sostenibile una situazione di potenziale rischio per
gli allievi e per il personale delle nostre scuole. Stiamo lavorando, a questo
proposito, ad un patto per la sicurezza dei nostri ragazzi, attraverso un nuovo
accordo tra ministero, regioni e autonomie locali, che renda disponibili nuove
risorse in un ambito pluriennale e che elimini definitivamente la prassi delle
proroghe, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 626.
Per uscire dall'emergenza
riguardante la spesa per l'istruzione, il mio intendimento è quello di
analizzare a fondo il bilancio del ministero. Lo farò anche con il supporto di
tecnici esterni - state tranquilli, senza aggravio di spese! -, perché voglio
verificare gli eventuali sprechi di risorse e i motivi dell'incessante
diminuzione delle risorse attribuite dalla legge n. 440 all'autonomia
scolastica. Inoltre, voglio impedire che esistano sprechi, per giungere insieme
alla consapevolezza che non è il Ministero della pubblica istruzione il
dicastero dove si spende comunque troppo e comunque male. È un'operazione
preliminare della massima importanza, per poter poi avviare politiche di
razionalizzazione e di qualificazione della spesa. Ci sono molte diversità
nell'allocazione delle risorse tra le diverse aree territoriali e tra le
diverse regioni ed anche tra i diversi segmenti dell'istruzione, di cui occorre
approfondire l'entità e le cause.
È certo, comunque, che il sistema
educativo non può più sopportare tagli indiscriminati. La penuria provoca
asfissia e pericolosi ripiegamenti o, viceversa, un disordinato e concitato
muoversi delle autonomie scolastiche, per trovare, attraverso i più diversi
progetti, le risorse necessarie ad un funzionamento decente delle istituzioni
scolastiche. È anche insostenibile, per la dignità stessa del ruolo
dell'istruzione pubblica nel nostro paese, che ci si debba rivolgere, in molte
realtà, al contributo economico delle famiglie, per far fronte alle spese di
ordinario funzionamento, dalla carta per le stampanti a quella per i servizi
igienici, dalle carte geografiche alla manutenzione delle attrezzature
informatiche. Perfino per la retribuzione delle commissioni degli esami di
maturità, ho trovato una situazione, che non esito a definire scandalosa, di
prolungata non assegnazione delle risorse necessarie, a monte di un'erogazione
di lavoro certa e prevista per legge. Ho dovuto intervenire - come sapete, con
un provvedimento che il Parlamento si accinge ad approvare - con la logica del
tappabuchi. Una situazione di questo tipo, aggiunta alle restrizioni
finanziarie piovute in questi ultimi anni sugli enti locali - che sostengono
una parte importantissima di spese per il funzionamento della scuola -, deve
riuscire a trovare un rimedio.
Uscire dalle
emergenze è obbligatorio. Per farlo è, però, necessario: primo, eliminare, se
ci sono, gli sprechi di risorse, dislocando tutto ciò che non è indispensabile
all'azione dell'amministrazione sulle autonomie scolastiche; secondo,
razionalizzare e riqualificare la spesa, tenendo conto sia di specificità
preziose del nostro sistema educativo (come l'integrazione dei diversamente
abili), sia di alcune emergenze e priorità (come l'integrazione scolastica
degli immigrati e lo sviluppo dei livelli di istruzione degli adulti); terzo,
modificare, in questo quadro, la fisionomia del bilancio della pubblica
istruzione, non basandolo più solo sulla spesa corrente, ma anche sugli
investimenti strategici.
Tutto ciò
comporta la definizione, in base a criteri oggettivi e scientifici, dei livelli
appropriati o essenziali delle prestazioni del sapere, e quindi della spesa pro
capite per studente necessaria per raggiungere questi obiettivi formativi.
Anche per questa via, dunque, si
torna inevitabilmente al grande ritardo del nostro sistema, relativamente alla
definizione degli standard di riferimento dell'azione educativa e alla
necessità di superarlo in tempi brevi. Le autonomie scolastiche hanno bisogno
di questo salto di qualità, per poter passare dalla scuola dei programmi e
delle procedure ministeriali a quella della progettazione dei curricula,
per poter valutare i risultati ottenuti e per potersi autovalutare. Si tratta
di un punto di grandissima importanza, decisivo per la qualità della scuola, a
cui dobbiamo dedicare il massimo impegno. Attenzione ed indirizzo necessitano
anche di fondi strutturali che riceviamo dall'Unione europea e di tutti gli
altri fondi che riceviamo da altre fonti, perché siano inseriti a pieno titolo
nel sostegno all'autonomia scolastica e alle vere esigenze di una scuola che è
in marcia verso l'eccellenza.
La definizione
degli obiettivi formativi, dei livelli appropriati delle prestazioni, degli standard
di riferimento - che è compito dello Stato - è la sola via possibile per
realizzare quello che ci chiede anche l'Europa, cioè la trasparenza e la
compatibilità dei percorsi e dei risultati del nostro sistema educativo. Un
passaggio, del resto, indispensabile per fondare su basi solide la validità
legale dei titoli di studio e il loro riconoscimento in ambito europeo.
A questo
obiettivo hanno un interesse diretto le famiglie, che hanno il diritto di
conoscere i risultati del sistema e delle singole scuole, misurati in modo
scientifico sulla base di parametri definiti, ma anche le autonomie scolastiche
e gli insegnanti, per poter orientare la loro azione, superare le criticità,
misurarsi con la ricerca dei possibili miglioramenti e leggere con chiarezza i
risultati.
I dispositivi di
valutazione finora attivati, che hanno avuto comunque il pregio di sviluppare
una familiarizzazione delle scuole con le tematiche della valutazione, hanno
molti limiti: quello strutturale di non riferirsi ad obiettivi formativi chiari
e condivisi e quelli tecnici intrinseci alle modalità di somministrazione delle
prove e ad altri aspetti non secondari. Occorre, dunque, contestualmente
all'impegno principale - che riguarda l'individuazione degli standard di
riferimento dell'attività formativa -, rivedere alcuni elementi specifici delle
tecniche di valutazione.
Gli obiettivi da perseguire - lo
ripeto per evitare ogni possibile fraintendimento - sono comunque quelli di
approdare alla definizione dei criteri scientifici di valutabilità del sistema
e delle singole istituzioni scolastiche, anche come supporto
all'autovalutazione professionale degli insegnanti. La valutazione delle
singole scuole è propedeutica a qualsiasi tipo di altra valutazione, che
comunque non è, oggi, al nostro ordine del giorno.
Affronto ora il
tema della scuola secondaria superiore. Se per il primo ciclo di istruzione c'è
bisogno di modifiche mirate, da realizzarsi con il metodo del «cacciavite», e
di un processo di rivisitazione, supportato dai pareri e dalle competenze di
chi opera concretamente nella scuola, di specifici dispositivi e delle
indicazioni nazionali, per il secondo ciclo abbiamo bisogno di più tempo. Le
questioni in campo, infatti, sono molto complesse e più lungo e complesso sarà
l'ascolto degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. È decisivo, in questo
quadro, attivare l'ascolto attento degli studenti e dei genitori, sentire le
loro proposte, coinvolgerli nella definizione delle loro scelte.
Per questo,
oltre ad aver bloccato una sperimentazione che era stata contestata dalle
regioni e che non poteva, in effetti, disporre di tutte le condizioni
necessarie ad una realizzazione significativa per l'intero sistema, abbiamo
presentato al Parlamento una proroga di diciotto mesi per i decreti legislativi
non scaduti della legge-delega n. 53 del 2003 e per il conseguente differimento
al 2008-2009 dell'entrata in vigore. È un tempo necessario per impostare
correttamente e in progress la realizzazione degli obiettivi contenuti
nel programma di Governo.
Circa la volontà
di elevare l'obbligo d'istruzione scolastica, due anni in più di istruzione
sono necessari non solo per consolidare ed innalzare le competenze di base di
tutti, ma anche per consentire di effettuare le scelte di indirizzo e di
percorso ad una età non troppo acerba e con una maggiore consapevolezza, da
parte dei giovani e delle loro famiglie, delle propensioni e delle attitudini
effettive. Non si può scegliere, come è noto, ad occhi chiusi, né solo sulla
base delle aspettative dei nuclei familiari e delle aspirazioni connesse con le
condizioni sociali di appartenenza. Costringere i ragazzi a scegliere troppo presto
significa esporli al rischio non solo di decisioni che appartengono più al
destino sociale che alla maturazione di un livello sufficiente di
autorientamento, ma anche di scelte che ignorano o rimuovono i talenti
effettivi di ciascuno. E una scuola che mette al centro i diritti della persona
questa cosa non può e non deve mai farla. Né deve farlo una società democratica
che vuole essere una società aperta.
Due anni in più
di istruzione significano anche, come ho già accennato, innalzare dai quindici
ai sedici anni l'età minima per l'ingresso al lavoro. Una decisione, del resto,
in linea con il rispetto che dobbiamo alla delicata età dell'adolescenza, oltre
che con la riluttanza di gran parte del mondo imprenditoriale all'inserimento
nella struttura produttiva di ragazzi troppo giovani. È passata molta acqua
sotto i ponti - e per fortuna - rispetto ai tempi in cui i figli dei ceti
sociali più modesti passavano direttamente dall'infanzia alle responsabilità e
alle durezze della vita adulta, anche se il dramma del lavoro minorile nel
nostro paese riguarda ancora 145 mila unità. Tra i sedici e i diciotto anni,
come si è già sottolineato, ogni attività lavorativa - come in altri paesi
dell'Unione europea - deve essere integrata da una forte dimensione formativa.
Se il diritto all'istruzione, a partire da una certa età, non può annullare il
diritto al lavoro, è però il lavoro che deve declinarsi sulla necessità che
anche i giovani che si inseriscono presto nel mercato del lavoro abbiano le
stesse opportunità degli altri di conseguire qualifiche professionali e titoli
di studio. Passa di qui, come è noto, l'incremento dell'occupabilità delle
persone - cioè la loro forza soggettiva di misurarsi con successo con le
difficoltà e le incertezze che caratterizzano oggi il lavoro - e la loro stessa
possibilità di continuare ad apprendere per tutto il corso della vita.
Per ciò che
riguarda il nuovo biennio, la sua fisionomia dovrà essere tale da contemperare
diverse esigenze: l'innalzamento delle competenze di base per tutti; lo
sviluppo e la verifica degli orientamenti e delle propensioni di ciascuno;
l'abbattimento drastico dell'insuccesso scolastico, della demotivazione e degli
abbandoni, attraverso una didattica capace di valorizzare le attitudini
cognitive e le aspettative dei ragazzi e delle ragazze.
Una scommessa
non semplice, come è dimostrato dal fatto che proprio sulla difficoltà di
individuare soluzioni culturali ed organizzative equilibrate, attente alle
esigenze di ciascuno, si è arenata da più di trent'anni un'ipotesi di riforma
del secondo ciclo che fosse sufficientemente condivisa. Occorrono, dunque, un
monitoraggio attento delle esperienze in atto, il supporto di idee e di
proposte del sistema educativo reale, l'analisi dei fabbisogni professionali
del sistema produttivo e dei servizi.
È, comunque, evidente che un
biennio rigidamente scolastico, in cui la realizzazione dei suoi diversi
compiti fosse affidata unicamente all'articolazione del curriculum in
discipline generali e di indirizzo, rischierebbe di riprodurre i fenomeni di
dispersione scolastica e di esclusione formativa, che vogliamo invece
contrastare. È, dunque, importantissimo che il nuovo biennio, utilizzando
soprattutto la quota di monte-ore affidata all'autonomia scolastica, che, come
sapete, ho riconfermato al 20 per cento sui curricula, e attivando
linguaggi e metodologie didattiche diverse da quelle tradizionali, sappia
valorizzare le diverse intelligenze e i diversi talenti dei ragazzi. Ed è
altrettanto importante, anche nel quadro del Titolo V, che le autonomie
scolastiche e gli attori istituzionali responsabili della programmazione
dell'offerta formativa, sappiano predisporre i percorsi più adatti a rendere
attraenti ed efficaci i percorsi formativi, tenendo conto sia delle diverse
tipologie della dispersione in questa fascia di età, sia delle risorse
formative attivabili nel territorio.
Il nostro paese,
infatti, non è affatto omogeneo dal punto di vista delle risorse locali del
sistema educativo e tale omogeneità non è immediatamente realizzabile.
D'altro canto,
anche la dispersione non è un fenomeno che presenti, sempre e dovunque, le
stesse caratteristiche: l'insuccesso scolastico di Scampia e dei quartieri
spagnoli di Napoli non è la stessa cosa degli abbandoni precoci determinati
dall'attrattività di un inserimento immediato nel mercato lavoro di alcune aree
del nord-est, e neppure la stessa cosa della rinuncia di tanti figli
dell'immigrazione, dopo la scuola media, a proseguire in qualsiasi ulteriore
percorso formativo. C'è, inoltre, un rischio di dispersione che può essere
contenuto e limitato con una didattica più attenta e con l'integrazione di
attività di orientamento e formazione professionale dentro il percorso di
istruzione. Mentre, in altri casi ci si deve misurare con un rifiuto netto di
qualsiasi tipo di aula, anche la più arricchita di attività di laboratorio. È,
in ogni caso, evidente che è il livello locale quello che consente di avere il
quadro preciso dei diversi bisogni formativi, il contesto privilegiato della
progettazione organizzativa e didattica.
Decisiva, a questo proposito, è
l'attivazione di anagrafi regionali e provinciali, complete e aggiornate di
tutti i soggetti «in obbligo» e di efficaci servizi di orientamento delle
famiglie e dei ragazzi. I ritardi che si sono accumulati su questo punto in
diverse aree regionali sono tra le criticità più acute del nostro sistema.
Non si possono
attivare gli interventi di recupero degli abbandoni se non si accerta,
scientificamente e in modo aggiornato, l'entità e i bisogni formativi dei drop-out:
quelli che escono dalla scuola media senza licenza o in tale ritardo scolastico
da rinunciare ad ogni proseguimento dell'apprendimento per via formale; quelli
che si disperdono nel passaggio dalla scuola media alla superiore; quelli che
cadono nei primi anni della scuola superiore; quelli che abbandonano i percorsi
di formazione professionale o che escono precocemente dall'apprendistato; i
tanti «minori stranieri ricongiunti», o arrivati da soli nel nostro paese, di
cui il nostro sistema scolastico non ha traccia.
In tema di
valorizzazione dell'istruzione tecnica e professionale, voglio dire che gli
istituti tecnici e gli istituti professionali costituiscono, insieme, oltre il
60 per cento del secondo ciclo di istruzione. La loro importanza non è però
solo numerica, perché essi costituiscono il canale attraverso cui la
maggioranza degli studenti consegue titoli che consentono sia il proseguimento
degli studi nell'istruzione superiore, accademica e non accademica, sia le
competenze professionali per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Storicamente, sono stati gli
istituti tecnici ad assicurare le figure e i profili professionali
indispensabili alla nostra industria manifatturiera e molti di essi sono
tuttora i «fiori all'occhiello» di singole aziende o di distretti industriali.
Il calo di iscrizioni, che li caratterizza ormai da una decina di anni, deriva
da un insieme di fattori, tra cui è della massima importanza la crisi,
nell'immaginario stesso dei giovani e delle famiglie, anche nel nord-ovest, del
prestigio sociale dell'industria e delle figure professionali che vi fanno
riferimento. Ma gli istituti tecnici restano un percorso formativo della
massima importanza per il paese e per i giovani. È importante che i titoli
finali consentano anche l'iscrizione all'università, ma lo è altrettanto che la
maggioranza dei diplomati entri direttamente nel mercato del lavoro.
La
valorizzazione dell'istruzione tecnica, di cui lo sviluppo del paese ha
grandissimo bisogno, non passa dall'improbabile «licealizzazione» decisa
nell'ultima legislatura. In questa scelta vi è la perdita del valore
professionalizzante dei titoli finali e la riduzione della parte di curriculum
destinata alla formazione di tipo laboratoriale. Si tratta di una scelta - non
a caso duramente contestata da tutte le associazioni di impresa del paese -, in
cui sono del tutto evidenti culture antiche ed obsolete che non riconoscono il
profilo e la complessità della cultura tecnologica e neppure la sua densità
culturale, umanistica e scientifica. Gli istituti tecnici e professionali,
dunque, devono essere modernizzati nell'impianto culturale e didattico; devono
però essere tenuti lontani da processi di assimilazione, tout court, ai
licei generalisti.
Anche
l'istruzione professionale statale - che rappresenta il 23 per cento circa
della scuola secondaria superiore e che, a differenza degli istituti tecnici,
non ha subito in questi ultimi anni un calo di iscrizione - ha bisogno urgente
di modernizzazione ed innovazione, a partire dal carico eccessivo di discipline
e di saperi segmentati, che è causa non secondaria dell'alto tasso di
dispersione che si verifica nei primi due anni. Tra le sue caratteristiche più
interessanti, che ne fanno un'area di attrazione dei giovani, che all'uscita dalla
scuola media non sono propensi a percorsi formativi lunghi e tantomeno a
percorsi che conducono obbligatoriamente al post-secondario, c'è ormai
una lunga tradizione di rapporto con i mercati del lavoro locali e la
possibilità di conseguire una qualifica professionale di validità nazionale, la
duratura esperienza di integrazione tra scuola e formazione professionale, tra
formazione e lavoro.
Quello che
abbiamo scritto nel programma del Governo, cioè il proposito di valorizzare
l'area formativa tecnico-professionale - nell'ambito di una più generale
valorizzazione dei percorsi di carattere scientifico - conduce necessariamente
ad averne una visione unitaria, che escluda lo spacchettamento tra tecnici e
professionali, che deriverebbe, a mio avviso, da una lettura riduttiva di
quanto disposto dal Titolo V. Dobbiamo, al contrario, ricondurre in un'unica
area gli istituti tecnici e professionali, integrarne le risorse - come già
stanno facendo numerose sperimentazioni - anche con l'apporto dei sistemi
locali di formazione professionale, flessibilizzarne il funzionamento in modo
da assicurare la possibilità di conseguimento di qualifiche e di diplomi
professionalizzanti di più livelli diversi. Tutto ciò senza alcun pregiudizio
delle competenze in merito a tutto ciò che è titolo professionalizzante da
parte delle regioni.
La valorizzazione dell'area
tecnico-professionale richiede, per esser davvero tale, interventi importanti,
sia monte, sia a valle. A monte, significa che anche nella scuola di base le
discipline e le attività di carattere tecnologico non devono essere considerate
- come del resto auspicavano gli stessi programma degli anni settanta - puro
spazio applicativo delle conoscenze teoriche, cioè figli di un dio
(culturalmente) minore. A valle, significa che occorre sviluppare percorsi
formativi di tipo tecnico-professionale di alta specializzazione, post-secondari,
ma non necessariamente di natura accademica. L'esperienza di corsi di
formazione e istruzione tecnica superiore e la progettazione regionale di poli
formativi «di campo», collegati con la ricerca scientifica e con i sistemi
produttivi di riferimento, sono già passi in avanti in questa direzione, passi
a mio avviso molto importanti.
Sono passaggi
cruciali anche per contrastare il calo delle cosiddette vocazioni scientifiche.
Tale calo, infatti, non è solo il risultato delle scarse prospettive di impiego
dei giovani che si formano in questi campi, in un paese in cui la ricerca
pubblica è stritolata dalla penuria di investimenti politici ed economici, la
ricerca privata è ridotta al lumicino e le aziende preferiscono assumere
diplomati e licenziati della scuola media, piuttosto che laureati (come ci
segnalano incessantemente le indagini EXCELSIOR). La distanza cresciuta negli
ultimi anni dal sapere scientifico e tecnologico dobbiamo assolutamente
colmarla.
Su questi temi,
assolutamente strategici per una moderna configurazione del secondo ciclo, il
nostro impegno deve essere altissimo. Non sfugge a nessuno, infatti, la loro
importanza per un nuovo sviluppo del paese, e noi dobbiamo, in questo settore,
investire.
L'attenzione
alla cultura e alla formazione tecnico-professionale va, però, coniugata con
quella dedicata alla riqualificazione, alla modernizzazione e al rilancio degli
indirizzi di carattere umanistico, anch'essi decisivi per lo sviluppo di un
paese. Mi ostino a ritenere ancora che la scuola debba avere un ruolo
essenziale come artefice di un processo di umanizzazione delle nuove
generazioni. Il nostro paese, caratterizzato non solo da un patrimonio
eccezionale di beni culturali, ma anche da produzioni artistiche e culturali di
grandissima importanza, anche dal punto di vista economico, non può non avere
un ruolo decisivo nel sistema educativo in questi campi. A tale proposito,
svilupperemo un impegno comune tra il Ministero dell'istruzione e quello dei
beni e delle attività culturali.
In questo
quadro, l'educazione musicale e artistica deve essere valorizzata nel ciclo di
base e nel secondo ciclo, sia all'interno dei curricula di ogni indirizzo,
sia con l'istituzione di percorsi specialistici finalizzati al conseguimento di
qualifiche professionali e di diplomi. Gli stessi poli di istruzione e
formazione tecnica superiore, collegati alla ricerca, che oggi stanno
progettando le regioni, devono essere declinati anche in questo senso.
Per ciò che
riguarda gli esami di Stato, la composizione attuale delle commissioni di esame
ha confermato e rafforzato la fisionomia di un sistema educativo che rischia,
se non corretto, di andare progressivamente ad attenuare, in tutto il percorso
degli studi, il valore formativo delle prove, l'importanza dell'impegno nello
studio e il significato del merito individuale.
Il dispositivo
dei «debiti» e dei «crediti», non sostenuto da strumenti efficaci ed in tempi
certi di recupero dei deficit accumulati, può avere effetti qualche
volta diseducativi, proprio come un esame finale in cui c'è perfetta
coincidenza tra chi ha erogato la formazione e chi ne giudica i risultati
finali. Le critiche di moltissimi studenti, che denunciano l'«inutilità» delle
prove di maturità, sono il segno di desideri positivi di cambiamento. Anche
qui, dunque, bisogna cambiare, restituendo valore e dignità al lavoro
dell'apprendimento e dell'insegnamento, in primo luogo ripristinando la presenza
dei commissari esterni nelle commissioni degli esami di Stato.
Tra i modi per
restituire tutto il loro significato ai percorsi di studio, c'è anche la
valorizzazione delle politiche di orientamento, che riguardano
l'implementazione sia dei rapporti tra il sistema educativo e il mondo del
lavoro e delle professioni, sia di quelli con l'università e con i percorsi di
istruzione superiore non accademica. Occorre riflettere inoltre sulla
possibilità di inserire, all'interno delle commissioni che valutano gli accessi
alle facoltà universitarie, insegnanti della scuola media superiore.
Dal prossimo
settembre avrà inizio una campagna di ascolto delle scuole su tutti i temi di
maggiore importanza e, in particolare, su quelli che riguardano il secondo
ciclo. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli studenti, le famiglie
saranno coinvolti nell'approfondimento dei cambiamenti necessari ed
auspicabili.
Con gli studenti
e con le famiglie, discuteremo in particolare anche proposte innovative di
sviluppo dell'educazione motoria, sanitaria, ambientale e alla legalità. Si
tratta di campi importanti per la responsabilizzazione dei giovani rispetto a
sé stessi, agli altri e ai beni comuni. Una cura particolare sarà data al
rapporto tra educazione e salute, alla prevenzione delle dipendenze e dei
disturbi alimentari.
Avremo bisogno
di costruire le condizioni, a partire dal prossimo DPEF, per tenere aperte le
scuole anche di pomeriggio, coinvolgendo le famiglie e gli attori del
territorio (enti locali, fondazioni, imprese): è un modo importante per far
crescere la responsabilità dei ragazzi rispetto alle proprie scuole e per dare
loro spazi di incontro e cooperazione.
A questa
campagna di ascolto tengo molto. Io stesso mi impegno a partecipare a eventi e
incontri regionali, perché sono certo che è solo attraverso un processo di
condivisione che si possono affrontare questioni così vaste e di tale
complessità.
Non ci saranno,
dunque, nuove edizioni di «Stati Generali» un po' verticistici e neppure altri
manifesti evocativi di un nuovo mondo o di perentoria rottura con un mondo
considerato vecchio o da buttare. Sono convinto che la scuola italiana
apprezzerà anche un lavoro teso a dare una quotidianità dignitosa agli
insegnanti ed un sapere al passo con l'Europa ai nostri studenti.